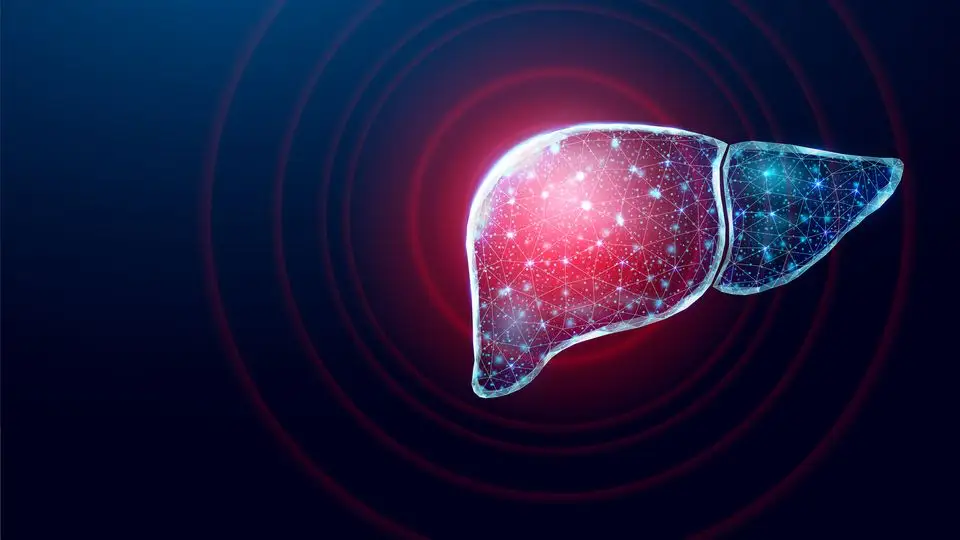La psoriasi rappresenta una condizione complessa in cui sistema immunitario, genetica e ambiente interagiscono in modo dinamico
La psoriasi è una patologia cronica di origine infiammatoria, nella quale il sistema immunitario svolge un ruolo determinante. Le sue cause precise non sono ancora state individuate, ma la ricerca evidenzia l’interazione tra predisposizioni genetiche, fattori ambientali e alterazioni del sistema di difesa dell’organismo.

A livello globale, questa condizione interessa circa il 2-3% della popolazione adulta, e presenta manifestazioni cliniche eterogenee
Sulla pelle compaiono tipicamente placche spesse e ben delimitate, ricoperte da squame, accompagnate da rossore, prurito o desquamazione. La psoriasi non si limita all’ambito cutaneo: può coinvolgere anche articolazioni e occhi, ed è spesso associata ad altre malattie sistemiche, come disturbi cardiovascolari, sindrome metabolica e depressione.
Alla base di queste manifestazioni vi è un processo infiammatorio diffuso in tutto l’organismo, non confinato alla pelle, ma capace di influenzare il corretto equilibrio di diversi organi e apparati.
Meccanismi immunitari e molecole coinvolte
Nel meccanismo che alimenta la psoriasi, un ruolo fondamentale è svolto dalle citochine IL-23 e IL-17, che formano un asse di segnalazione chiave. L’IL-23 favorisce la maturazione delle cellule Th17, responsabili della produzione di IL-17A, IL-17F e altre molecole pro-infiammatorie.
Queste sostanze stimolano un’eccessiva crescita dei cheratinociti (le cellule dell’epidermide), modificandone la normale differenziazione e inducendo la sintesi di peptidi antimicrobici, chemochine e mediatori infiammatori come IL-6, TNF-α e IFN-γ. Oltre a questo asse principale, sono coinvolti altri meccanismi immunitari: la produzione di IFN-α da parte delle cellule dendritiche plasmacitoidi (pDC), l’attivazione di neutrofili e l’attivazione dei percorsi intracellulari NF-κB e MAPK, che amplificano la risposta infiammatoria e ne favoriscono la cronicizzazione.
Fattori genetici, ambientali e scatenanti
La comparsa della psoriasi è influenzata da numerosi elementi predisponenti e da fattori esterni. Tra quelli genetici si annoverano particolari varianti come l’allele HLA-C*06:02 e mutazioni in geni correlati al sistema immunitario, tra cui CARD14 e i recettori dell’IL-23.
Le cause ambientali includono infezioni — in particolare faringiti da streptococco ma anche infezioni batteriche, fungine o virali — e traumi cutanei che possono innescare il fenomeno di Koebner, ovvero la formazione di nuove lesioni in corrispondenza di zone lesionate.
Anche lo stress psicologico gioca un ruolo rilevante: livelli elevati di stress intensificano l’attività infiammatoria dell’asse IL-23/Th17, aggravando la sintomatologia. Infine, abitudini di vita scorrette come fumo, abuso di alcol, sedentarietà, dieta sbilanciata e obesità aumentano la suscettibilità e la gravità della malattia.
Barriera cutanea e microbiota
La pelle non rappresenta soltanto un rivestimento esterno, ma anche una barriera immunologica complessa.
Quando questa barriera subisce danni — per esempio in seguito a abrasioni o traumi — possono liberarsi componenti cellulari come DNA danneggiato o peptidi antimicrobici (LL-37). Queste sostanze possono combinarsi e innescare l’attivazione delle pDC, cellule che avviano risposte immunitarie anomale.
Parallelamente, alterazioni nel microbiota cutaneo e intestinale (disbiosi) possono contribuire all’infiammazione, aumentando la permeabilità intestinale e la produzione di molecole microbiche, come i lipopolisaccaridi, che stimolano ulteriormente il sistema immunitario.
In condizioni normali, le cellule della pelle completano il loro ciclo vitale in circa 28-30 giorni. Nella psoriasi, invece, questo processo è estremamente rapido: i cheratinociti maturano e si accumulano sulla superficie cutanea nel giro di pochi giorni.
Il risultato è la formazione delle tipiche placche spesse e squamose, accompagnate da arrossamenti, irritazioni e ispessimenti visibili.
L’infiammazione, inoltre, non resta localizzata: comporta vasodilatazione, infiltrazione di cellule immunitarie e aumento della circolazione locale, con effetti sistemici che possono favorire la comparsa di malattie associate.
Terapie mirate e farmaci biologici
L’evoluzione della ricerca medica ha portato allo sviluppo di terapie biologiche capaci di agire in modo selettivo sui meccanismi infiammatori della psoriasi.
Tra queste troviamo:
- Inibitori dell’IL-17 (come secukinumab, ixekizumab, brodalumab), che neutralizzano direttamente la citochina o i suoi recettori.
- Antagonisti dell’IL-23 (guselkumab, risankizumab, tildrakizumab), che bloccano la subunità p19 di questa molecola; ustekinumab invece agisce sulla subunità p40, comune anche all’IL-12.
- Farmaci anti-TNF-α, i primi biologici introdotti, tuttora efficaci ma associati a un maggior rischio di immunosoppressione.
Ricerche emergenti esplorano ulteriori strategie, tra cui la modulazione delle cellule dendritiche e delle cellule T della memoria residente (TRM), che rimangono nella cute anche dopo la remissione e possono spiegare la recidiva delle lesioni.
Sono inoltre in fase di studio farmaci che mirano a IL-36, IL-1, IL-6 e a vie intracellulari come STAT3, NF-κB e MAPK, con l’obiettivo di ridurre selettivamente l’infiammazione.
Stile di vita e gestione complementare
Oltre ai trattamenti farmacologici, la gestione della psoriasi richiede attenzione agli stili di vita. Numerose evidenze dimostrano che le modifiche comportamentali possono ridurre i livelli di infiammazione e migliorare la risposta alle terapie.
- Controllo del peso corporeo: il sovrappeso e l’obesità aumentano la produzione di citochine infiammatorie come IL-6 e TNF-α. La perdita di peso è spesso associata a una netta riduzione della severità della psoriasi.
- Alimentazione bilanciata: privilegiare alimenti ricchi di fibre, verdure, frutta e acidi grassi omega-3, riducendo zuccheri raffinati e grassi saturi. Una dieta equilibrata aiuta anche a riequilibrare il microbiota intestinale.
- Attività fisica regolare: l’esercizio favorisce la circolazione, riduce la sedentarietà e contribuisce al benessere immunitario.
- Gestione dello stress: pratiche come yoga, meditazione o psicoterapia possono ridurre l’attivazione immunitaria indotta dallo stress cronico.
- Sonno adeguato: un riposo sufficiente sostiene il sistema immunitario e limita l’infiammazione.
- Astensione da fumo e alcol, entrambi fattori che peggiorano la condizione infiammatoria e possono interferire con i trattamenti farmacologici.
Quando consultare un dermatologo
È consigliabile rivolgersi a uno specialista in caso di riacutizzazione persistente, comparsa di dolori articolari o segni di artrite psoriasica, oppure quando le terapie in corso non risultano efficaci.
Il dermatologo o il medico curante potrà valutare la gravità e l’estensione della malattia, proporre un trattamento su misura, consigliare correzioni nello stile di vita e monitorare la presenza di eventuali comorbidità.
Direzioni future della ricerca
Le prospettive di ricerca puntano a chiarire i meccanismi iniziali dell’infiammazione, compreso il ruolo della barriera cutanea, del microbiota e delle cellule della memoria immunitaria. Si mira inoltre a individuare biomarcatori predittivi della risposta terapeutica, per scegliere il trattamento più efficace per ciascun paziente.
Gli obiettivi futuri comprendono lo sviluppo di farmaci più selettivi e meno tossici, capaci di modulare l’attività infiammatoria senza compromettere le difese dell’organismo, e l’attuazione di strategie preventive nei soggetti geneticamente predisposti o esposti a fattori di rischio.