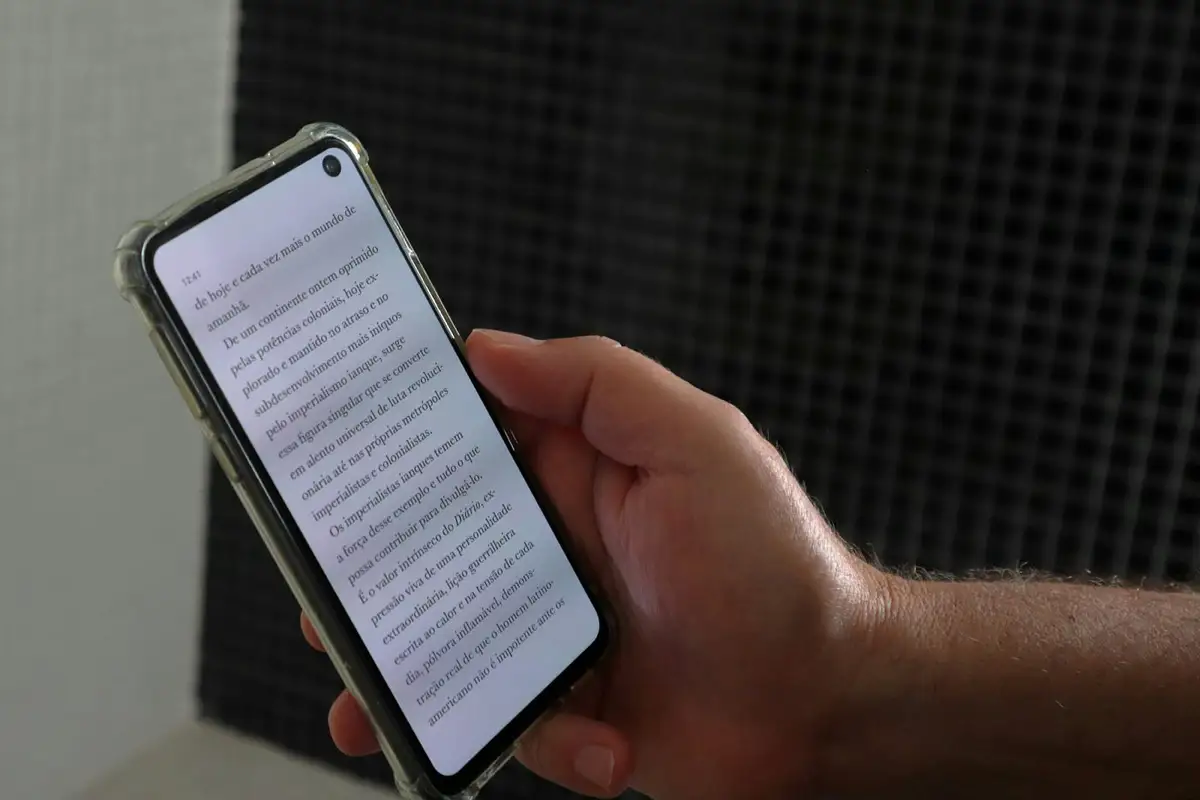Contrastare l’atrofia cognitiva da scroll, ecco come ritrovare la concentrazione nell’era dello scroll infinito
Negli ultimi anni, la scienza cognitiva ha registrato un cambiamento profondo nel modo in cui gli esseri umani gestiscono l’attenzione. L’esposizione continua a messaggi frammentati, notifiche e flussi infiniti di contenuti digitali ha ridotto drasticamente la capacità di mantenere la mente concentrata su un’unica attività.
Uno studio apparso su Nature Communications nel 2023 ha descritto questo fenomeno come una condizione di “attenzione parzialmente costante”: un continuo stato di vigilanza dispersiva che costringe il cervello a reagire in modo frammentario, impedendo la concentrazione prolungata.
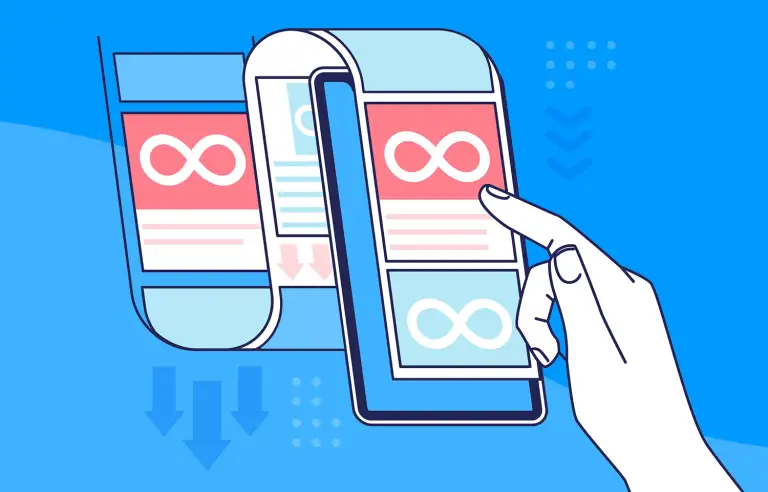
L’esperienza di Emma Loffhagen rivela una verità semplice ma cruciale: allenare l’attenzione non richiede strumenti complessi, ma gesti costanti
È dentro questo contesto che si inserisce la testimonianza della giornalista britannica Emma Loffhagen, che nel suo articolo pubblicato sul Guardian racconta la propria battaglia personale contro il collasso dell’attenzione. La sua strategia di resistenza mentale è tanto semplice quanto potente: tenere traccia di ogni nuova parola incontrata, trasformando un gesto linguistico in un vero esercizio di recupero cognitivo.
Dalla passione per i libri alla distrazione costante
Loffhagen ricorda con nostalgia gli anni dell’infanzia, quando passava ore intere immersa nei romanzi senza percepire la fatica. Crescendo, quella capacità di concentrazione si è dissolta, sostituita da una continua attrazione verso lo smartphone e dai meccanismi ipnotici dello “scroll infinito”.
Leggere, un tempo rifugio e piacere, è diventato un esercizio di disciplina. Gli studiosi chiamano questo processo “atrofia cognitiva digitale”, un deterioramento progressivo dell’attenzione documentato da ricercatori come Gloria Mark dell’Università della California, Irvine. Le sue ricerche mostrano che il tempo medio di concentrazione su un compito è sceso da oltre due minuti nel 2004 a meno di un minuto nel 2023.
Il diario delle parole: un rimedio alla dispersione
Per invertire questa deriva, Loffhagen ha introdotto nella sua vita una pratica minimale ma trasformativa: ogni volta che si imbatte in un termine ignoto, lo cerca, lo trascrive e lo rilegge periodicamente.
Niente quaderni eleganti o app sofisticate: solo un semplice documento sul telefono, che nel corso di un anno ha raggiunto quasi venti pagine. Ogni parola annotata rappresenta per lei una piccola conquista di consapevolezza, un segnale che la mente è tornata ad accendersi.
Secondo il neuroscienziato David Eagleman, apprendere e memorizzare nuovi vocaboli coinvolge i circuiti cerebrali della memoria e della flessibilità cognitiva. Questo tipo di esercizio stimola la neuroplasticità, ossia la capacità del cervello di creare connessioni nuove e di adattarsi, contrastando così l’effetto narcotico della distrazione digitale.
Scrivere come forma di allenamento mentale
Loffhagen spiega che il suo rituale non ha nulla di vanitoso: non serve a sfoggiare un linguaggio forbito, ma a riattivare i muscoli mentali dell’attenzione. Ogni parola appuntata, anche se raramente usata, agisce come una microstimolazione cognitiva.
La psicologa Maryanne Wolf, esperta di processi di lettura profonda, ha definito pratiche simili come strumenti in grado di “rallentare” la mente e riaccendere le reti neuronali della concentrazione profonda, spesso inibite dall’uso costante dei dispositivi digitali.
Riflettere su un termine e riscriverlo, dunque, significa rieducare il cervello alla lentezza: un esercizio essenziale per tornare a comprendere testi complessi e pensieri articolati.
Le difficoltà di un’abitudine lenta
Naturalmente, la pratica non è priva di ostacoli. Fermarsi nel mezzo di una lettura per consultare il significato di una parola può diventare frustrante, soprattutto in luoghi affollati o in movimento. L’autrice racconta di aver spesso dovuto interrompere la lettura in metropolitana per digitare un termine, attirando sguardi curiosi o impazienti.
Inoltre, la revisione settimanale delle parole raccolte richiede costanza, e non sempre viene rispettata. Solo una piccola parte — circa il 5% — entra realmente a far parte del suo linguaggio quotidiano. Eppure, anche con una resa linguistica minima, l’effetto mentale resta significativo: la pratica affina la memoria, migliora la consapevolezza linguistica e riattiva il piacere di pensare in modo più preciso.
Annotare parole, studiarle, ricordarle — anche senza un uso immediato — diventa un modo per restituire elasticità al cervello e profondità al pensiero.
In un’epoca in cui la velocità domina ogni ambito della vita mentale, pratiche lente come questa dimostrano che il linguaggio non è solo un mezzo di comunicazione, ma anche una palestra per la mente, capace di ridare forma e forza alla concentrazione perduta.
Rallentare per pensare meglio
L’aspetto più interessante di questo metodo è la sua natura paradossale: lo stesso dispositivo che prosciuga l’attenzione viene trasformato in strumento di concentrazione. In un ecosistema digitale costruito per moltiplicare le distrazioni, usare lo smartphone per riflettere, cercare e memorizzare diventa un gesto controcorrente, quasi sovversivo.
Un’indagine del Pew Research Center (2025) ha evidenziato che oltre un terzo dei lettori digitali sta adottando pratiche analoghe — dai diari di parole alle letture lente su carta — per recuperare il controllo della propria attenzione. Si tratta di una forma moderna di “resistenza cognitiva”, un modo per difendere la mente dai ritmi imposti dall’iperconnessione.
In un altro articolo, apparso sempre sul Guardian e firmato da Justine Toh, si riflette sul modo in cui l’uso costante dei dispositivi digitali e dei social network ha ridotto la capacità umana di essere presenti nel momento. L’autrice descrive l’“economia dell’attenzione” come un sistema che prospera tenendo gli individui incollati agli schermi, rendendo difficile vivere con consapevolezza.
L’immagine centrale del testo è quella di una “coppa vuota dell’attenzione”, tratta da un romanzo di Henry James, simbolo della disponibilità ad ascoltare e a concedere tempo e presenza agli altri. Tale “vuoto” rappresenta la calma e la pazienza necessarie per lasciare che le relazioni e i momenti respirino, qualità sempre più rare in una società dominata dallo scorrimento infinito dei contenuti.
L’autrice osserva che la distrazione costante non è un fenomeno recente: già C. S. Lewis, negli anni ’50, descriveva il tumulto mentale che assale ogni mattina, paragonandolo a un branco di animali selvatici. Oggi quella stessa agitazione è alimentata dal richiamo dei feed digitali.
Il testo propone la preghiera o la meditazione come pratiche capaci di restituire attenzione e presenza. Citando Santa Teresa d’Ávila, viene evocata l’immagine dell’anima come un castello di cristallo attraversato da diversi “appartamenti” o gradi di crescita spirituale: per accedervi occorre superare le distrazioni e i desideri che ne ostruiscono l’ingresso.
- Emma LoffhagenThe one change that worked: I was lost in the infinite scroll – until a small ritual renewed my love of reading