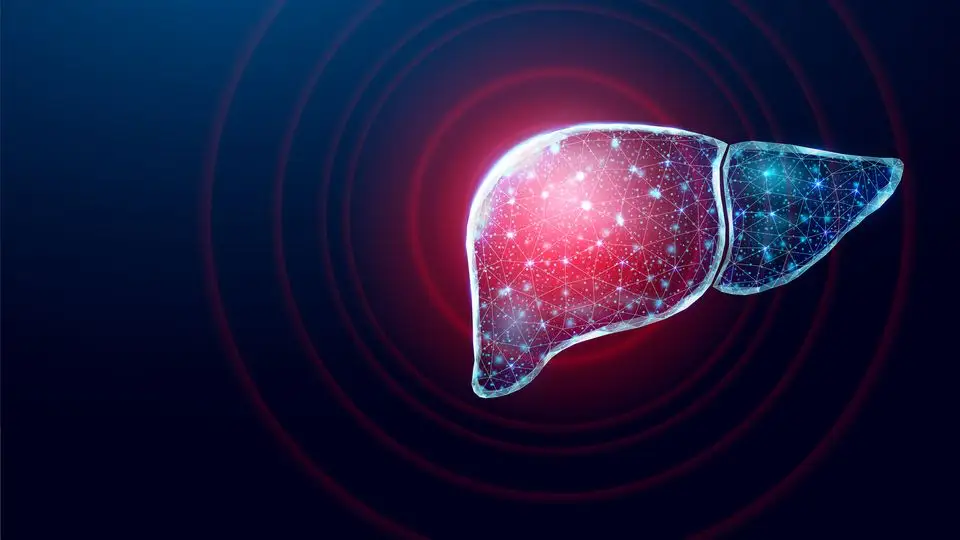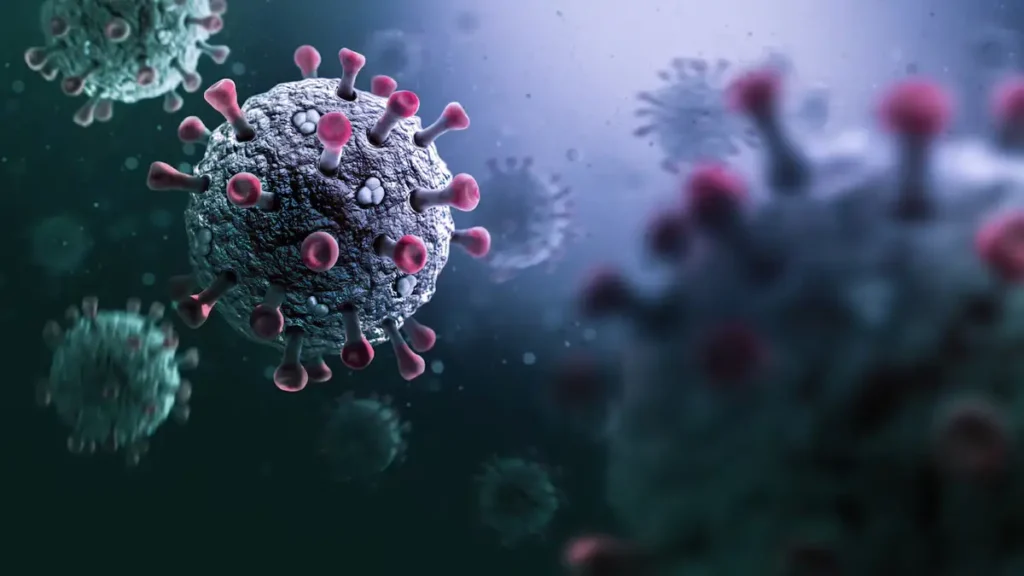La steatosi epatica rappresenta una sfida crescente per la salute pubblica, con una prevalenza in aumento e potenziali complicanze gravi
La steatosi epatica, comunemente conosciuta come “fegato grasso“, è una condizione patologica caratterizzata dall’accumulo eccessivo di lipidi all’interno delle cellule epatiche (epatociti). Sebbene inizialmente asintomatica, questa malattia può evolvere in forme più gravi, come la steatoepatite non alcolica (NASH), la cirrosi epatica e, nei casi più estremi, il carcinoma epatocellulare. Recenti dati epidemiologici evidenziano un preoccupante aumento dei casi a livello globale, con un incremento del 15% rispetto a venti anni fa, rendendo la steatosi epatica la malattia epatica più diffusa al mondo.

La diagnosi precoce e la gestione adeguata della malattia sono fondamentali per prevenire la progressione verso forme più severe. L’adozione di tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale, offre nuove opportunità per migliorare la precisione diagnostica e personalizzare i trattamenti
Epidemiologia e fattori di rischio
Secondo le stime, circa il 38% della popolazione adulta globale è affetta da steatosi epatica, con una prevalenza che varia tra il 20% e il 40% in Italia. La forma più comune di steatosi non alcolica è la MASLD (Metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease), strettamente correlata a disfunzioni metaboliche come obesità, diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e alterazioni del profilo lipidico. Questi fattori di rischio sono spesso associati a stili di vita sedentari e a diete ricche di grassi e zuccheri.
Diagnosi: un percorso articolato
La diagnosi di steatosi epatica si basa su un approccio multidisciplinare che include:
- Esami ematici. La valutazione dei livelli di enzimi epatici (transaminasi GOT e GPT), gamma-glutamiltransferasi (GGT), fosfatasi alcalina e profilo lipidico (colesterolo totale, LDL, HDL e trigliceridi) fornisce indicazioni sulla funzionalità epatica e sullo stato metabolico del paziente.
- Imaging addominale. L’ecografia addominale è il primo esame strumentale utilizzato per rilevare l’iperecogenicità epatica, segno tipico della steatosi. Altri strumenti diagnostici includono la tomografia assiale computerizzata (TAC) e la risonanza magnetica (RM), che offrono informazioni più dettagliate sulla composizione e sulla struttura del fegato.
- Fibroscan. Questa tecnica di elastografia epatica non invasiva misura la rigidità del fegato, fornendo indicazioni sul grado di fibrosi presente.
- Biopsia epatica. Considerata il gold standard per la diagnosi di steatoepatite non alcolica (NASH in inglese), la biopsia consente di valutare istologicamente la presenza di grasso, infiammazione e danno cellulare. Essendo un procedimento invasivo, viene riservata ai casi in cui gli altri esami non siano sufficienti a definire la diagnosi.
Evoluzione della malattia: da steatosi a steatoepatite
La steatosi epatica semplice è una condizione benigna, ma in alcuni casi può evolvere in steatoepatite non alcolica (NASH), caratterizzata da infiammazione e danno ai tessuti epatici. La NASH può progredire verso la cirrosi epatica, una condizione caratterizzata da fibrosi avanzata del fegato, e aumentare il rischio di sviluppare carcinoma epatocellulare. La presenza di sindrome metabolica (obesità, diabete, ipertensione e dislipidemia) è un indicatore importante per la diagnosi di NASH e per la valutazione del rischio di progressione della malattia.
Trattamenti e approcci terapeutici
Attualmente, non esiste un trattamento farmacologico specifico approvato per la steatosi epatica non alcolica. Sono in fase di sviluppo diversi farmaci, tra cui agonisti selettivi dei recettori degli ormoni tiroidei, che hanno mostrato promettenti risultati nel ridurre il grasso epatico, l’infiammazione e la fibrosi, migliorando anche i livelli di colesterolo LDL e trigliceridi.
Il trattamento principale rimane la modifica dello stile di vita, che include:
- Dieta equilibrata. Adottare una dieta sana e bilanciata, preferibilmente basata sul modello della dieta mediterranea, che enfatizza il consumo di frutta, verdura, cereali integrali e grassi sani.
- Attività fisica regolare. Praticare almeno 30 minuti di attività fisica moderata al giorno, come camminare a passo svelto, per migliorare la sensibilità all’insulina e ridurre il grasso corporeo.
- Controllo del peso. La perdita di peso, anche modesta, può ridurre significativamente il rischio di progressione della malattia.
- Monitoraggio medico. Sottoporsi a controlli regolari per valutare l’efficacia delle modifiche dello stile di vita e per monitorare eventuali segni di progressione della malattia.
Il ruolo dell’intelligenza artificiale nella diagnosi e gestione
L’intelligenza artificiale (IA) sta emergendo come uno strumento innovativo in epatologia, con applicazioni che spaziano dalla diagnostica per immagini alla medicina personalizzata. Un esempio significativo è l’adozione del tool AIM-NASH, sviluppato per analizzare le biopsie epatiche. Questo strumento, approvato dall’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), è stato addestrato su oltre 100.000 annotazioni di 59 patologi e su più di 5.000 biopsie provenienti da nove trial clinici. AIM-NASH ha dimostrato di valutare con elevata affidabilità infiammazione e fibrosi, riducendo la variabilità diagnostica rispetto allo standard convenzionale.
Nonostante le difficoltà legate alla standardizzazione dei dati e all’interpretabilità dei modelli, l’IA appare promettente nella gestione clinica della NAFLD e nella previsione dei rischi. La ricerca futura dovrebbe concentrarsi sulla fusione di dati multimodali, sulla traduzione clinica e sulla valutazione del valore pratico degli strumenti, favorendo la realizzazione della medicina di precisione assistita dall’IA per questa patologia. Lo studio fornisce inoltre una panoramica attuale delle applicazioni dell’IA nella MASLD e un riferimento per sviluppi futuri.
In Italia, è stato avviato lo studio nazionale Ita-MASLD, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità con la partecipazione del Club Epatologi Ospedalieri (Cleo). Questo studio mira a raccogliere dati di “real world evidence” per migliorare la comprensione della malattia e ottimizzare le strategie diagnostiche e terapeutiche.
- Front Radiol. 2025;10:1634165. doi: 10.3389/fradi.2025.1634165The evolution of artificial intelligence technology in non-alcoholic fatty liver disease
- Journal of Liver TransplantationCurrent techniques and future trends in the diagnosis of hepatic steatosis in liver donors: A review