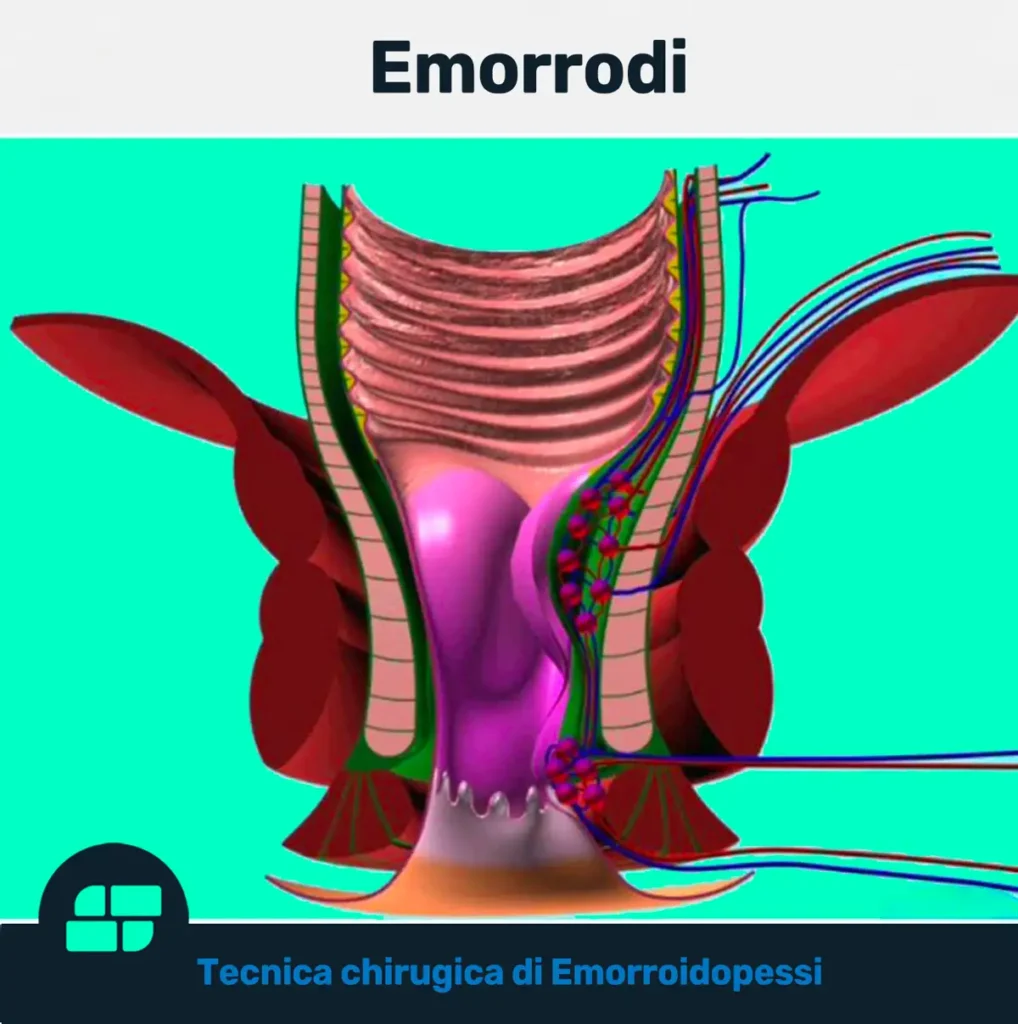Lo shock anafilattico, noto anche come anafilassi, è una reazione allergica severa che si manifesta in modo rapido e coinvolge diversi organi e sistemi dell'organismo
L’anafilassi rappresenta una delle emergenze mediche più gravi in ambito allergologico e può compromettere rapidamente le funzioni vitali, rendendo necessario un intervento tempestivo per evitare conseguenze potenzialmente fatali.
L’anafilassi si innesca quando il sistema immunitario di una persona sensibilizzata entra nuovamente in contatto con un allergene già incontrato in passato. A questo punto, l’organismo attiva anticorpi specifici di tipo IgE che riconoscono l’allergene come minaccia, inducendo una reazione infiammatoria intensa.
Questa risposta immunitaria determina la liberazione di mediatori chimici come:
- Istamina, che provoca dilatazione dei vasi sanguigni e aumento della loro permeabilità, con conseguente calo della pressione arteriosa (ipotensione);
- Leucotrieni e prostaglandine, che restringono i bronchi provocando difficoltà respiratoria;
- Altri mediatori responsabili del gonfiore dei tessuti (edema) e dell’eruzione cutanea.
I sintomi possono comparire in pochi minuti dall’esposizione all’allergene e includere orticaria, prurito, edema del volto o delle labbra, senso di costrizione toracica, respiro affannoso, nausea, vomito, perdita di coscienza e, nei casi più gravi, arresto cardiaco.
Un aspetto critico dell’anafilassi è che fino al 20% dei casi può manifestarsi senza i classici sintomi cutanei, rendendo la diagnosi più difficile e aumentando il rischio di ritardo nel trattamento.

Sai di essere allergico a un agente o alimento? La prevenzione è fondamentale
Principali Cause di Shock Anafilattico
Le cause dell’anafilassi sono molteplici e possono variare a seconda dell’età, dello stile di vita e dell’ambiente di esposizione. Tra le principali, si segnalano:
Farmaci
I medicinali rappresentano una delle cause più comuni. In particolare, lo shock può essere provocato da:
- Antibiotici come penicillina, ampicillina, cefalosporine, sulfamidici, tetracicline,
- Anestetici locali (es. difenidramina),
- Mezzi di contrasto iodati usati per esami diagnostici,
- Antinfiammatori non steroidei (FANS) come aspirina e ibuprofene,
- Insulina e altri ormoni iniettabili,
- Emoderivati e vaccini.
Veleni di Animali
Le punture o i morsi di alcuni animali sono tra i fattori scatenanti più pericolosi:
- Punture di insetti come api, vespe e calabroni (imenotteri),
- Morsi di serpenti,
- Punture di formiche rosse.
Alimenti
Alcuni cibi possono causare gravi reazioni allergiche, soprattutto nei bambini e nei giovani adulti:
- Arachidi, crostacei, latte, uova, noci, soia, grano e pesce.
Altri Agenti
- Lattice naturale, spesso presente in guanti, cateteri o dispositivi medici,
- Test allergici intradermici o di provocazione,
- Immunoterapie specifiche per allergie respiratorie o da veleno di insetti.
In circa un quinto dei casi, non è possibile identificare l’allergene scatenante: si parla in questo caso di anafilassi idiopatica.
Reazioni Anafilattoidi
Esistono anche reazioni simili all’anafilassi, ma con un meccanismo diverso. Le cosiddette reazioni anafilattoidi (oggi definite “anafilassi non IgE-mediata”) non coinvolgono gli anticorpi IgE, ma causano ugualmente il rilascio di sostanze vasoattive.
Queste reazioni possono insorgere in seguito a:
- Ingestione di cibi contenenti amine biogene (come istamina e tiramina), ad esempio pesce conservato male, formaggi fermentati, cioccolato, fragole;
- Somministrazione di alcuni farmaci o mezzi di contrasto.
- Anche se il meccanismo è differente, le manifestazioni cliniche e il trattamento sono gli stessi dell’anafilassi IgE-mediata.
Fattori di Rischio
Alcuni soggetti presentano un rischio maggiore di sviluppare uno shock anafilattico. I principali fattori predisponenti sono:
- Familiarità e predisposizione genetica: chi ha parenti allergici ha una maggiore probabilità di sviluppare reazioni simili.
- Allergie già note: la presenza di allergie alimentari, respiratorie o da contatto aumenta il rischio.
- Precedenti episodi di anafilassi: una storia clinica di anafilassi è un segnale importante.
- Età avanzata: gli anziani sono più vulnerabili, anche per l’uso frequente di farmaci.
- Uso di ACE-inibitori: questi farmaci per la pressione possono ridurre la capacità dell’organismo di contrastare una crisi anafilattica.
- Via di esposizione: iniezioni o punture (esposizione parenterale) comportano un rischio più alto rispetto a ingestione o inalazione.
Prevenzione e Cosa Fare in Caso di Emergenza
La prevenzione si basa principalmente sull’identificazione dell’allergene e sulla sua evitazione. Nei soggetti a rischio è fondamentale:
- Portare con sé un kit di emergenza contenente adrenalina autoiniettabile (es. Epipen),
- Informare familiari, colleghi e personale scolastico della propria condizione allergica,
- Indossare un braccialetto medico identificativo,
- Consultare un allergologo per un piano d’azione personalizzato.
In caso di reazione anafilattica, è cruciale:
- Somministrare immediatamente adrenalina intramuscolare,
- Chiamare il numero di emergenza (112 in Italia),
- Posizionare la persona sdraiata con le gambe sollevate, se cosciente,
- Evitare di somministrare cibo, bevande o farmaci per bocca.
- Il trattamento deve essere proseguito in ambiente ospedaliero per monitorare eventuali reazioni tardive.
Lo shock anafilattico è una condizione grave ma prevenibile e gestibile con adeguate conoscenze e strumenti. Essere informati sui propri fattori di rischio, sapere riconoscere i sintomi e agire prontamente può fare la differenza tra la vita e la morte. La sensibilizzazione pubblica e la formazione dei cittadini su come intervenire in caso di anafilassi sono fondamentali per ridurre la mortalità legata a questa emergenza medica.
Lo shock anafilattico è una reazione allergica sistemica, rapida e grave, causata da una risposta immunitaria sproporzionata a una sostanza innocua, denominata allergene. Dal punto di vista fisiologico, il meccanismo alla base coinvolge anticorpi IgE che, nei soggetti sensibilizzati, attivano mastociti e basofili. Queste cellule liberano mediatori come istamina, leucotrieni, prostaglandine e citochine, provocando vasodilatazione, broncospasmo e infiammazione generalizzata.
Le conseguenze sull’organismo si manifestano in più sistemi:
- Cardiovascolare: vasodilatazione e aumento della permeabilità capillare causano ipotensione e, nei casi gravi, collasso e insufficienza multiorgano.
- Respiratorio: si verifica ostruzione delle vie aeree per broncocostrizione ed edema laringeo, con possibile difficoltà respiratoria e cianosi.
- Cutaneo: si presentano orticaria, angioedema e prurito.
- Gastrointestinale: nausea, vomito, dolori addominali e diarrea.
L’insieme di queste reazioni può compromettere gravemente l’equilibrio interno (omeostasi) e portare, senza trattamento immediato con adrenalina e supporti medici, a insufficienza respiratoria, shock circolatorio o arresto cardiaco. Per questo, lo shock anafilattico richiede un intervento medico urgente e una pronta identificazione dei segnali clinici.
Shock Anafilattico: Sintesi delle Azioni da Compiere e da Evitare
In caso di sospetto shock anafilattico, è fondamentale:
- Allertare tempestivamente i soccorsi sanitari.
- Conoscere, anche a livello generale, le principali manovre di primo soccorso. Il trattamento principale è di competenza medica e prevede la somministrazione endovenosa di adrenalina (epinefrina), preferibilmente tramite infusione continua. A questo trattamento si associano soluzioni elettrolitiche o colloidali per contrastare l’ipotensione e la dispersione di liquidi nei tessuti. Altri farmaci possono essere somministrati in base al livello di compromissione degli organi vitali.
- Nei casi meno gravi, può essere sufficiente l’associazione di adrenalina, antistaminici e corticosteroidi. In situazioni più serie, è necessario garantire la pervietà delle vie respiratorie mediante ossigenoterapia o, in casi estremi, interventi chirurgici.
Il paziente deve essere posizionato supino con le gambe sollevate di circa 30 cm, o, se possibile, nella posizione di Trendelenburg (con la testa più bassa rispetto al bacino), per favorire il ritorno venoso al cuore e al cervello.
È importante rassicurare la persona colpita e mantenerla calma in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.
Non estrarre il pungiglione di un’ape con pinzette o con le dita, per evitare un rilascio maggiore di veleno. Meglio raschiarlo via con un oggetto rigido (come una carta di credito). Tuttavia, studi recenti evidenziano che la rapidità di rimozione è più importante della tecnica utilizzata.
Non adottare la posizione antishock se si sospettano traumi alla testa, al collo, alla schiena o agli arti inferiori.
In presenza di difficoltà respiratorie, non sollevare la testa con cuscini né somministrare liquidi, cibi o farmaci per via orale, poiché ciò potrebbe ostruire ulteriormente le vie respiratorie.