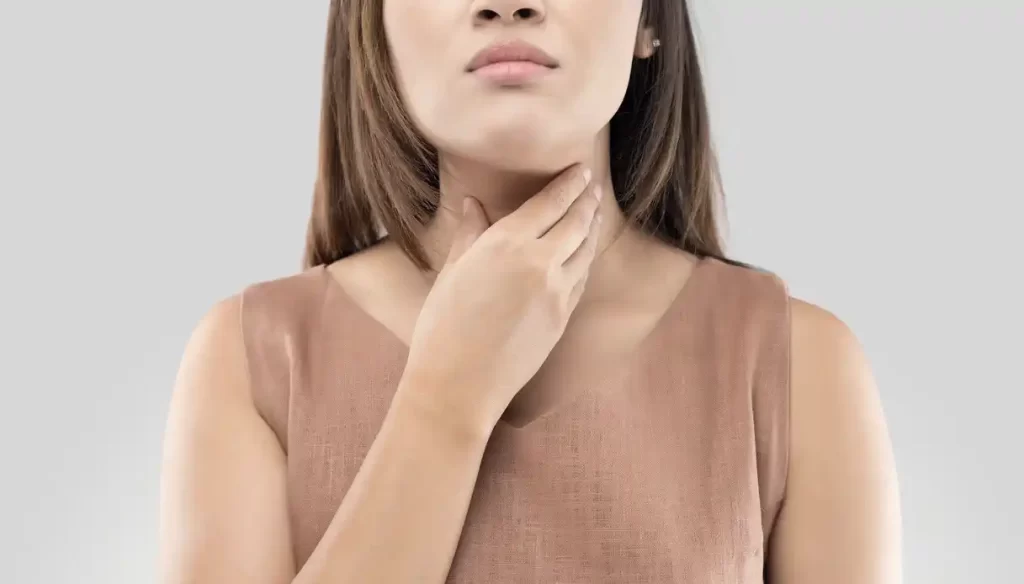Epicondilite sintomi, cause, diagnosi e trattamenti efficaci per il dolore al gomito. Scopri come riconoscerla e prevenirla con consigli medici aggiornati
L’epicondilite, comunemente identificata come “gomito del tennista” (lato esterno) o “gomito del golfista” (lato interno), è una patologia a carico dei tendini che si inseriscono sui condili dell’omero. Si tratta di una sofferenza tendinea non infiammatoria, causata da un uso eccessivo e ripetuto del polso e dell’avambraccio. In particolare, la forma laterale colpisce spesso il tendine dell’extensor carpi radialis brevis (ECRB), mentre quella mediale coinvolge i tendini dei muscoli flessori. La causa principale è l’accumulo di microtraumi, che determinano un deterioramento progressivo della struttura del tendine.
È una condizione frequente, soprattutto tra chi svolge attività che sollecitano ripetutamente il gomito. Il riconoscimento precoce, associato a un’educazione del paziente e a un piano terapeutico mirato, consente nella maggior parte dei casi una guarigione completa senza ricorrere alla chirurgia. Un approccio multidisciplinare che coinvolga medici, fisioterapisti e specialisti può ottimizzare i risultati, migliorando la qualità della vita del paziente
L’epicondilite interessa ogni anno circa l’1-3% degli adulti, con maggiore frequenza nella fascia tra i 35 e i 55 anni, colpendo in modo uniforme uomini e donne. Solitamente si manifesta nel braccio dominante e tende a insorgere in chi svolge attività manuali ripetitive, lavora con attrezzi vibranti o compie sforzi intensi con l’avambraccio. Anche obesità e fumo contribuiscono ad aumentare il rischio.
Sintomi Epicondilite
Sintomi
L’epicondilite, sia laterale che mediale, si presenta con un quadro sintomatologico riconoscibile e ben documentato nella letteratura medica internazionale.
Il sintomo più comune è un dolore localizzato in corrispondenza dell’epicondilo: nella forma laterale (nota come “gomito del tennista”) il dolore si concentra sulla parte esterna del gomito, mentre in quella mediale (detta “gomito del golfista“) si localizza sulla parte interna. Tale dolore può irradiarsi lungo l’avambraccio fino al polso. Spesso si avverte anche una sensazione di bruciore nella sede tendinea colpita, che può estendersi distalmente, contribuendo alla fastidiosità del quadro clinico.
Il dolore tende ad aumentare durante attività specifiche, in particolare nei movimenti che prevedono estensione o flessione del polso contro resistenza, come nel caso della presa di oggetti, torsioni o movimenti ripetitivi della mano e dell’avambraccio.
Può inoltre manifestarsi una debolezza funzionale, con difficoltà nel compiere gesti quotidiani come stringere la mano, sollevare oggetti o utilizzare utensili. Questo deficit si associa spesso a un dolore alla palpazione dell’epicondilo, rilevabile con manovre cliniche specifiche, come il test di Cozen per la forma laterale.
Tra i sintomi riferiti è frequente anche una certa rigidità, soprattutto al mattino o dopo periodi di inattività.
Nel caso dell’epicondilite mediale, non sono rari episodi di parestesie, come formicolii o intorpidimento, che coinvolgono in particolare il pollice e l’anulare, suggerendo un possibile interessamento nervoso.
| Sintomo | Descrizione | Fonte internazionale |
|---|---|---|
| Dolore epicondilo‑centrico | Sensazione dolorosa alla base del gomito, esterno (laterale) o interno (mediale), con possibili irradiazioni verso avambraccio e polso. | Mayo Clinic |
| Bruciore | Sensazione tipica di “bruciore” nella zona epicondilo‑centrica, elemento caratteristico dello stadio iniziale. | Healio |
| Dolore con resistenza | Anticipato o peggiorato da movimenti attivi e resistiti del polso o delle dita (es. test di Cozen). | Physiopedia, Wikipedia |
| Debolezza nella presa | Diminuzione della forza di presa o difficoltà a tenere oggetti comuni come penne, tazze o utensili. | Mayo Clinic, Physiopedia |
| Dolore alla palpazione | Fastidio o dolore acuto alla pressione sull’epicondilo. | Physiopedia, Wikipedia |
| Rigidità | Rigidità al risveglio o dopo rapidi cambi di attività. | Mayo Clinic |
| Parestesie (mediale) | Formicolii o intorpidimento nelle dita, tipico del golfer’s elbow con possibile coinvolgimento nervoso. | Mayo Clinic |
Contrariamente a quanto si pensa, non si tratta di un’infiammazione classica, ma di una degenerazione cronica del tendine (tendinosi). Le fibre di collagene all’interno del tendine perdono il loro orientamento normale, si osservano cambiamenti nei vasi sanguigni e un’alterazione della struttura del tessuto, senza la presenza significativa di cellule infiammatorie.
Nella maggior parte dei casi, la condizione migliora spontaneamente o grazie a trattamenti non invasivi nel giro di sei mesi fino a un anno. Circa l’80-90% delle persone guarisce senza interventi chirurgici. Tuttavia, in una piccola percentuale di pazienti con sintomi persistenti, si rende necessario un trattamento più aggressivo.
Diagnosi
Il primo passo prevede la raccolta di informazioni sullo stile di vita del paziente, con particolare attenzione ad attività ripetitive che possono aggravare i sintomi. Si osservano segnali come dolore durante l’uso dell’arto, perdita di forza o funzionalità, in assenza di disturbi neurologici evidenti. L’esame obiettivo consiste nella palpazione della zona dolente (epicondilo laterale o mediale) e nell’esecuzione di specifici test provocativi.
Tra i test più affidabili per l’epicondilite laterale vi è il Cozen Test, in cui l’estensione del polso contro resistenza provoca dolore, con un’alta sensibilità (fino al 91%). Il Mill Test, il Maudsley Test e altri, come il test della tazza di caffè (coffee-cup test), presentano una sensibilità compresa tra il 70% e l’88%. Per l’epicondilite mediale si utilizza il Golfer’s Elbow Test, che riproduce il dolore con movimenti specifici del polso.
L’ecografia è utile per visualizzare alterazioni tendinee (come calcificazioni o rotture), in particolare nella forma mediale. Le radiografie servono ad escludere malattie ossee concomitanti, mentre la risonanza magnetica (RMN) e l’elettromiografia (EMG) vengono riservate ai casi complessi o per valutare eventuali coinvolgimenti nervosi.
Tra gli strumenti di misurazione più utilizzati:
- PRTEE (Patient-Rated Tennis Elbow Evaluation): questionario specifico per l’epicondilite laterale, misura dolore e limitazioni funzionali.
- NPRS (Numerical Pain Rating Scale) e VAS (Visual Analog Scale): scale numeriche da 0 a 10 per quantificare l’intensità del dolore.
- Pain-Free Grip Test: test con dinamometro che misura la forza della presa manuale fino al limite del dolore.
- DASH/QuickDASH e PSFS: questionari generici per valutare la disabilità dell’arto superiore, utili come strumenti complementari.
Le principali organizzazioni sanitarie suggeriscono un approccio clinico razionale: l’American Academy of Family Physicians consiglia anamnesi accurata e test fisici, riservando esami strumentali ai casi che non rispondono al trattamento o in cui serve una diagnosi differenziale. L’Australian Physiotherapy Association, attraverso il toolkit CAD, raccomanda l’utilizzo combinato di PRTEE, NPRS, test di forza e test provocativi per una diagnosi completa e affidabile. Il PRTEE (Patient-Rated Tennis Elbow Evaluation) è un questionario mirato a misurare la gravità del dolore e le difficoltà funzionali associate all’epicondilite laterale. Composto da 15 domande suddivise in due sezioni, il punteggio totale varia da 0 (assenza di sintomi) a 100 (problema molto grave). Questo strumento è ampiamente utilizzato per la sua affidabilità e per la capacità di monitorare i cambiamenti nel tempo, sia in ambito riabilitativo sia chirurgico.
La NPRS (Numerical Pain Rating Scale) è una scala numerica che consente al paziente di quantificare il proprio dolore da 0 a 10, dove 0 indica nessun dolore e 10 il massimo dolore immaginabile. Si tratta di uno strumento rapido, soggettivo ma efficace, utile sia nelle fasi iniziali della diagnosi sia per valutare l’efficacia del trattamento.
Il Pain-Free Grip Test è un test di forza che misura la capacità di presa manuale utilizzando un dinamometro, ma solo fino al limite in cui non si avverte dolore. Questo test, ripetuto in condizioni standardizzate, permette di confrontare la forza del lato colpito con quella del lato sano, fornendo un indicatore oggettivo della funzione muscolare e dell’evoluzione clinica.
I test provocativi sono manovre cliniche volte a riprodurre il dolore tipico dell’epicondilite e a confermare la diagnosi. Tra i principali vi sono:
- Il Cozen Test, che prevede l’estensione del polso contro resistenza, con dolore al lato laterale del gomito indicativo di positività.
- Il Mill Test, che consiste nella flessione passiva del polso con il gomito esteso, provocando dolore sull’epicondilo laterale.
- Il Maudsley Test, che coinvolge l’estensione contro resistenza del dito medio, con dolore laterale come segno positivo.
- Il Golfer’s Elbow Test, specifico ma per l’epicondilite mediale, basato sulla flessione del polso contro resistenza o estensione passiva che causa dolore sul lato mediale del gomito.
| Aspetto diagnostico | Cosa significa per il paziente | Strumento / Test |
|---|---|---|
| Sintomi riferiti | Dolore nell’attività quotidiana, come sollevare oggetti o allacciarsi le scarpe | Domande durante la visita |
| Dolore alla palpazione | Il medico preme sull’esterno (o interno) del gomito: se fa male, è un segno diagnostico | Test del medico |
| Test provocativi | Ti viene chiesto di estendere o flettere il polso con resistenza: se senti dolore, è indicativo di epicondilite | Cozen, Mill, Maudsley, test del golfista |
| Domande su dolore e funzione | Scala da 0 a 100 che misura quanto ti fa male o quanto sei limitato nelle attività quotidiane | PRTEE |
| Valutazione del dolore | Indichi da 0 a 10 quanto ti fa male | Scala NPRS |
| Forza di presa senza dolore | Viene misurata con una pinza: serve per monitorare i progressi nelle prime fasi del trattamento | Pain‑Free Grip Test (dinamometro) |
| Ecografia / RX | Se serve confermare o escludere altri problemi, ti faranno un’ecografia o una radiografia | Ecografia, RX gomito |
| RMN / EMG | Utilizzate solo se il dolore non migliora o ci sono dubbi su possibili danni ai nervi o strutture più profonde | Risonanza magnetica, elettromiografia |
L’epicondilite, sia laterale che mediale, può essere influenzata da diverse condizioni patologiche che, pur non rappresentando una causa diretta, ne aumentano il rischio di insorgenza. Tali condizioni agiscono come fattori predisponenti o concausali, secondo quanto evidenziato dalla letteratura scientifica.
Tra i fattori che favoriscono lo sviluppo dell’epicondilite figurano l’obesità, il fumo, il diabete mellito, i disturbi posturali cronici, i movimenti manuali ripetitivi e l’invecchiamento. L’obesità incrementa il carico meccanico sui tendini, mentre il fumo compromette la microcircolazione, ostacolando i processi di riparazione tissutale. Il diabete provoca alterazioni strutturali del collagene, rendendo i tendini più vulnerabili. Le posture scorrette, in particolare sul lavoro, causano un uso anomalo dei tendini dell’avambraccio, così come le attività ripetitive costituiscono una causa meccanica diretta. Con l’età, infine, la minore elasticità e capacità rigenerativa dei tendini ne favorisce la degenerazione.
Condizioni che possono essere confuse con l’epicondilite (diagnosi differenziali):
| Condizione | Differenze cliniche principali |
|---|---|
| Radicolopatia cervicale (C5-C6) | Dolore irradiato al braccio, parestesie, alterazioni neurologiche |
| Sindrome del tunnel radiale | Dolore profondo e diffuso all’avambraccio, senza debolezza alla prensione |
| Borsite olecranica | Gonfiore evidente sul gomito, dolore più posteriore |
| Artrosi del gomito | Limitazione articolare importante, crepitii articolari |
| Osteocondrite dissecante del capitello radiale | Dolore nei giovani sportivi, limitazione dei movimenti |
| Nevralgia post-erpetica (herpes zoster) | Dolore neuropatico localizzato, in assenza di sollecitazioni tendinee |
Se non trattata adeguatamente, l’epicondilite può portare a complicazioni secondarie. Tra queste si segnalano la rottura del tendine, soprattutto in seguito a infiltrazioni prolungate con corticosteroidi o in presenza di degenerazione avanzata, la perdita cronica di forza nella prensione, le alterazioni biomeccaniche dovute a compensazioni posturali, e la cronicizzazione del dolore, con impatto negativo sulla qualità della vita.
Correlazioni dell’epicondilite con altre patologie o condizioni:
| Tipo di Relazione | Condizione associata | Tipo di Associazione | Meccanismo scientificamente accertato |
|---|---|---|---|
| Predisponente | Obesità | Rischio aumentato | Carico meccanico e stress tendineo |
| Predisponente | Fumo | Rischio aumentato | Vasocostrizione e degenerazione tendinea |
| Predisponente | Diabete | Rischio aumentato | Alterazioni metaboliche e del collagene |
| Predisponente | Invecchiamento | Fisiologico | Ridotta elasticità e rigenerazione |
| Causa meccanica | Attività ripetitive | Diretta | Microtraumi da sovraccarico |
| Diagnosi differenziale | Cervicobrachialgia | Possibile confusione | Irradiazione neurologica |
| Diagnosi differenziale | Radial tunnel syndrome | Simile per dolore | Compressione nervosa |
| Diagnosi differenziale | Borsite olecranica | Simile topograficamente | Infiammazione della borsa olecranica |
| Complicanza secondaria | Rottura del tendine | Indotta | Degenerazione cronica o steroidi |
| Complicanza secondaria | Dolore cronico | Evolutiva | Mancata risoluzione del quadro |
| Complicanza secondaria | Debolezza funzionale | Conseguenza indiretta | Ridotta funzionalità dell’arto superiore |
| Complicanza secondaria | Sovraccarico compensativo | Indotta | Adattamenti posturali secondari |
Trattamenti conservativi
Le cure non chirurgiche includono:
- Modifiche comportamentali: limitare le attività ripetitive e adottare una postura più corretta.
- Farmaci: l’uso di antinfiammatori (FANS) per il controllo del dolore.
- Ghiaccio locale: utile per ridurre il fastidio.
- Supporti ortopedici: fasce o tutori per alleviare la tensione sui tendini.
- Fisioterapia: esercizi mirati di allungamento e rinforzo eccentrico, spesso associati a tecniche manuali.
- Terapie fisiche: come laser, ultrasuoni o ionoforesi, con efficacia variabile.
- Infiltrazioni: i corticosteroidi offrono beneficio temporaneo ma comportano rischi; il plasma arricchito di piastrine (PRP) mostra potenzialità, anche se necessita ulteriori conferme scientifiche.
- Terapie alternative: come le onde d’urto o l’agopuntura, che non hanno ancora dimostrato un’efficacia significativa.
| Approccio Conservativo | Descrizione | Fonti e Link |
|---|---|---|
| Riposo e modifica attività | Riduzione o sospensione temporanea delle attività che aggravano il dolore, per favorire la guarigione | Mayo Clinic |
| Terapia fisica (fisioterapia) | Esercizi di stretching, rafforzamento e terapia manuale per migliorare la funzionalità e ridurre il dolore | Physio-Pedia |
| Terapia con ghiaccio | Applicazione di ghiaccio per ridurre infiammazione e dolore acuto | Cleveland Clinic |
| Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) | Utilizzo di ibuprofene o naprossene per controllare dolore e infiammazione | NIH – MedlinePlus |
| Tutori e ortesi | Uso di fasce o tutori specifici per ridurre lo stress tendineo | American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) |
| Onde d’urto extracorporee (ESWT) | Terapia che stimola la guarigione tramite onde sonore ad alta energia | Cochrane Review |
| Infiltrazioni di plasma ricco di piastrine (PRP) | Stimolazione biologica della riparazione tendinea tramite concentrazione piastrinica | PubMed Central |
| Educazione del paziente | Informazioni su corretta postura, ergonomia e tecniche per evitare recidive | Australian Physiotherapy Association |
Quando è necessario l’intervento chirurgico
La chirurgia è un’opzione da considerare solo quando il dolore persiste oltre i 6-12 mesi nonostante tutte le terapie conservative. L’operazione prevede la rimozione del tessuto tendineo danneggiato e, talvolta, la decorticazione dell’epicondilo per stimolare la rigenerazione. I risultati sono generalmente positivi, con successo nell’85-90% dei casi.
La prevenzione si basa sull’adozione di abitudini ergonomiche corrette, evitando movimenti ripetitivi e mantenendo una postura adatta. È utile eseguire esercizi di rinforzo per il polso e l’avambraccio, smettere di fumare e mantenere un peso salutare. L’uso corretto degli strumenti e l’attività fisica adeguata sono elementi chiave per limitare il rischio di sviluppare la patologia.