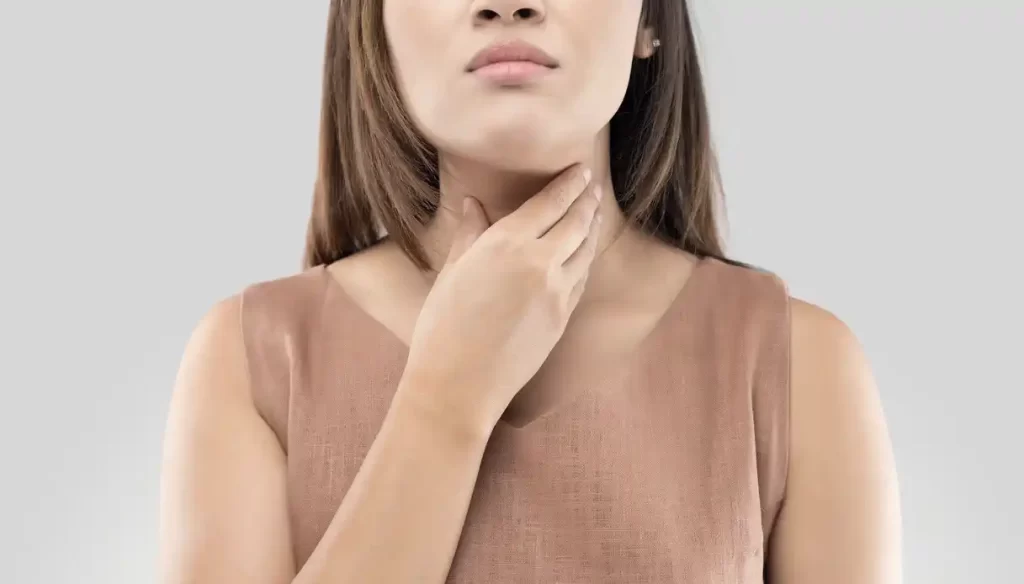Sindrome di Brugada: scopri sintomi, cause genetiche, diagnosi e trattamenti per prevenire aritmie e morte improvvisa
La Sindrome di Brugada è una rara malattia del cuore di origine genetica che si manifesta attraverso anomalie dell’attività elettrica del cuore, pur in assenza di difetti strutturali evidenti. Il disturbo è dovuto a un malfunzionamento dei canali ionici della membrana cellulare delle cellule cardiache, con conseguente alterazione della trasmissione degli impulsi elettrici. Questo fenomeno può predisporre chi ne è affetto a sviluppare aritmie ventricolari pericolose, potenzialmente letali.

Sindrome di Brugada: scopri sintomi, cause genetiche, diagnosi e trattamenti per prevenire aritmie e morte improvvisa. La Sindrome di Brugada: una patologia cardiaca genetica e silenziosa
La malattia è ereditaria e si trasmette con modalità autosomica dominante, ovvero ogni figlio di un genitore affetto ha il 50% di possibilità di ereditarla. Il principale gene coinvolto è lo SCN5A, che codifica per un canale del sodio essenziale al corretto funzionamento elettrico del cuore. Altri geni, come SCN10A, possono essere implicati. La sindrome si manifesta più frequentemente nel sesso maschile e in individui di origine asiatica. È rara nei bambini e nei neonati, ma può colpire anche giovani adulti senza alterazioni strutturali del cuore.
La sindrome di Brugada può avere una causa genetica nel 30-35% dei casi. In queste situazioni, la patologia deriva da una mutazione ereditaria che colpisce un gene legato a un canale di membrana presente soprattutto nelle cellule muscolari del cuore, oppure a una proteina correlata a tale canale. Nel restante 65-70% dei casi, invece, le origini del disturbo restano ancora sconosciute e non sono riconducibili in modo certo a fattori genetici o di altra natura. Proprio per questa ragione, la forma genetica è quella maggiormente analizzata e oggetto di studi approfonditi.
Sintomi e manifestazioni cliniche
La Sindrome di Brugada può rimanere a lungo asintomatica. Quando i sintomi si presentano, spesso compaiono in modo improvviso e senza preavviso. I più comuni sono:
- Svenimenti (sincope): dovuti a tachicardie ventricolari che causano una perdita momentanea di coscienza.
- Palpitazioni e sensazioni di malessere generale.
- Morte cardiaca improvvisa: evento drammatico, più frequente nei giovani tra i 25 e i 50 anni, dovuto a fibrillazione ventricolare.
Gli episodi si verificano più spesso durante il sonno o in momenti di riposo, piuttosto che durante l’attività fisica. Talvolta possono presentarsi anche episodi di enuresi notturna, riconducibili a sincope notturna con rilascio sfinteriale.
La sindrome di Brugada, in molti casi, non presenta sintomi evidenti fino all’età adulta, in genere tra i 30 e i 40 anni. In certe situazioni, può addirittura non dare mai segni di sé nel corso della vita.
Quando si manifesta, i sintomi sono spesso legati alla presenza di aritmie ventricolari, come la fibrillazione ventricolare o la tachicardia ventricolare polimorfa. Le principali manifestazioni cliniche includono:
- Perdita di coscienza (sincope);
- Sensazione di battito cardiaco irregolare (palpitazioni);
- Respiro affannoso (dispnea);
- Dolori al petto;
- Sensazione di instabilità o vertigini;
- Episodi convulsivi;
- Arresto cardiaco.
Tra i fattori che possono favorire o scatenare la comparsa del segno di Brugada si annoverano: la febbre elevata, squilibri elettrolitici come iperkaliemia, ipokaliemia o ipercalcemia, l’abuso di alcol, l’uso di cocaina e l’assunzione di alcuni farmaci, tra cui beta-bloccanti, medicinali a effetto vagotonico, antiaritmici di classe I (bloccanti dei canali del sodio), agonisti alfa-adrenergici e antidepressivi eterociclici.
È importante sottolineare che non tutti i pazienti sperimentano le forme più gravi della malattia. In alcuni individui, infatti, i sintomi possono essere più lievi. Tuttavia, si è osservato che la sindrome tende a manifestarsi prevalentemente durante il sonno o dopo aver consumato un pasto abbondante, più raramente in condizioni di riposo.
Diagnosi e accertamenti
La diagnosi della Sindrome di Brugada parte spesso da un tracciato ECG eseguito per altri motivi. Tuttavia, non sempre l’anomalia elettrocardiografica è presente in modo continuo, potendo variare anche nell’arco della stessa giornata. Le alterazioni tipiche includono un blocco di branca destra incompleto e sopraslivellamento del tratto ST in alcune derivazioni, con caratteristiche “a tenda” (diagnostiche) o “a sella” (sospette).

Un ECG che evidenzia la Sindrome dii Brugada
Gli esami diagnostici includono:
- Elettrocardiogramma a 12 derivazioni
- Holter ECG di 24 ore
- Ecocardiogramma (per escludere altre cardiopatie)
- Test da sforzo
- Test farmacologici con Ajmalina o Flecainide
- Studio elettrofisiologico intracavitario
Segno di Brugada: Definizione e Significato Clinico
Il segno di Brugada è un’anomalia specifica osservabile all’elettrocardiogramma (ECG), caratteristica dei soggetti con sindrome di Brugada. Tale alterazione del tracciato non si associa, nella maggior parte dei casi, a sintomi evidenti o disturbi percepibili.
Va sottolineato che, sebbene il segno di Brugada sia presente in tutti i pazienti affetti dalla sindrome, non tutte le persone che mostrano questo tracciato anomalo sono necessariamente portatrici della patologia. Per questo motivo, la rilevazione del segno richiede ulteriori indagini diagnostiche per determinare con precisione la natura del disturbo cardiaco.
Test genetici
Nel sospetto di patologia, è indispensabile rivolgersi a un aritmologo-elettrofisiologo per valutare i sintomi e approfondire il quadro clinico, anche in relazione alla storia familiare.
Alcune condizioni possono accentuare le anomalie elettrocardiografiche o scatenare aritmie, tra cui febbre, assunzione di cocaina, farmaci psichiatrici, e l’equilibrio instabile tra sistema simpatico e parasimpatico dopo esercizio fisico. Tali elementi aumentano il rischio di crisi aritmiche.
La sindrome è una delle principali cause di morte cardiaca improvvisa nei pazienti senza evidenti anomalie anatomiche del cuore, rappresentando fino al 20% dei decessi improvvisi in soggetti con cuore strutturalmente sano. Gli scienziati hanno identificato almeno 18 geni che, se soggetti a mutazioni, possono contribuire allo sviluppo della variante ereditaria della sindrome di Brugada. Tra tutti, il gene SCN5A rappresenta quello più spesso implicato: si stima che sia coinvolto in una percentuale di casi compresa tra il 10 e il 30%.
Il gene SCN5A, situato sul cromosoma 3, codifica per la subunità alfa di un canale del sodio che funziona in risposta ai cambiamenti di voltaggio. Questo canale ha un ruolo fondamentale nel trasmettere i segnali elettrici che permettono al cuore di contrarsi in maniera corretta. Quando SCN5A è alterato, produce un canale malfunzionante che ostacola il normale passaggio dei segnali elettrici all’interno del muscolo cardiaco.
Altri geni ritenuti potenzialmente coinvolti comprendono: SCN1B, SCN2B, SCN3B, SCN10A, ABCC9, GPD1L, CACNA1C, CACNB2, CACNA2D1, KCND3, KCNE3, KCNE1L (KCNE5), KCNJ8, HCN4, RANGRF, SLMAP e TRPM4.
La forma genetica della sindrome di Brugada è ereditaria e si trasmette principalmente secondo un modello autosomico dominante. Questo significa che è sufficiente ereditare una sola copia del gene mutato da uno dei genitori per poter sviluppare la patologia.
Il termine “autosomico” indica che il gene in questione non si trova sui cromosomi sessuali, mentre “dominante” sottolinea come la presenza della copia mutata sia sufficiente a prevalere sull’effetto della copia normale del gene. Di conseguenza, se anche solo uno dei due genitori possiede la mutazione genetica, il figlio ha una possibilità concreta di essere affetto dalla malattia.
Strategie terapeutiche
Non esistono farmaci in grado di prevenire in maniera sicura le aritmie ventricolari. Nei pazienti ad alto rischio (che hanno già avuto sincope o arresto cardiaco), si raccomanda l’impianto di un defibrillatore automatico (ICD), capace di monitorare il ritmo cardiaco e intervenire in caso di aritmie pericolose. Nei casi selezionati con aritmie ricorrenti, si può procedere a un’ablazione transcatetere delle zone responsabili.
Per chi si trova in una fascia di rischio intermedia, alcuni centri valutano anche terapie farmacologiche con chinidina. È fondamentale evitare farmaci che possano accentuare l’instabilità elettrica, come Flecainide o Propafenone.
Considerando l’origine genetica della sindrome, è fondamentale estendere la valutazione anche ai familiari del paziente. La storia clinica della famiglia può rivelare morti improvvise in giovane età, diagnosi erronee di epilessia (in realtà sincopi aritmiche), o aborti spontanei tardivi.
Tra i principali elementi che aumentano la probabilità di sviluppare la sindrome di Brugada, si annoverano:
- Familiarità e genetica: Avere un familiare diretto affetto dalla malattia incrementa il rischio di ereditarla, vista la trasmissibilità genetica.
- Genere maschile: Gli uomini sono statisticamente più soggetti a sviluppare la sindrome rispetto alle donne, probabilmente a causa di differenze ormonali.
- Origine etnica asiatica: Il disturbo è più diffuso tra le popolazioni asiatiche, in particolare tra gli individui provenienti da Thailandia e Laos.