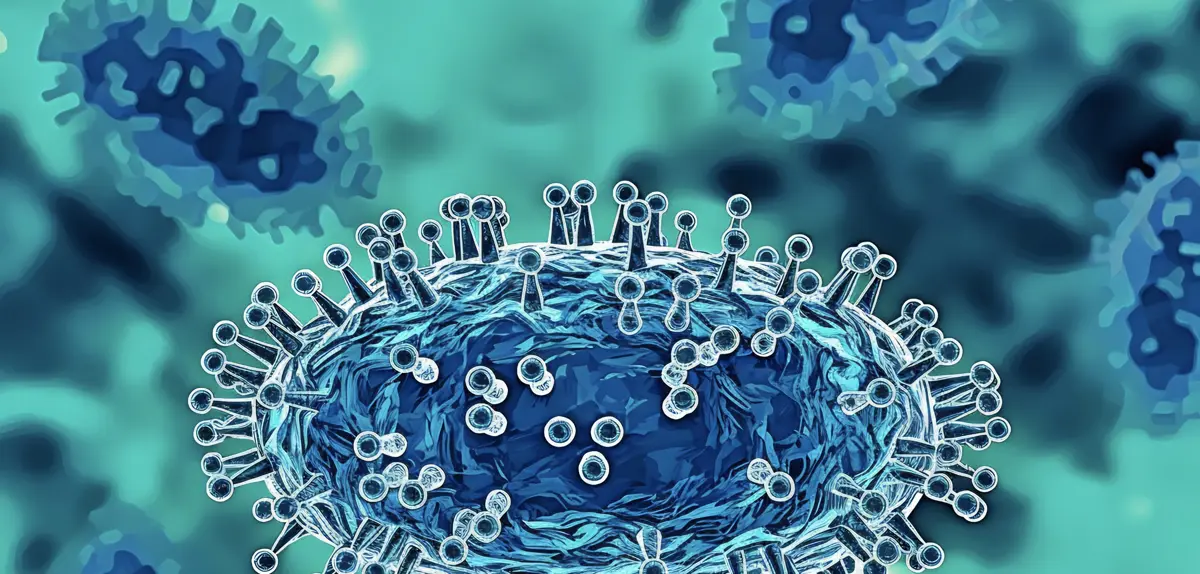Vaiolo trasmissione, diagnosi e complicazioni. Come viene diagnosticato il vaiolo, i metodi di laboratorio e l’importanza della prevenzione per evitare focolai
Il vaiolo è una patologia infettiva di origine virale che si trasmette con facilità tra esseri umani e si manifesta in forma acuta. Il responsabile della malattia è il virus Variola, parte della famiglia Poxviridae e classificato all’interno del genere Orthopoxvirus. Si tratta di un virus di dimensioni relativamente grandi, dotato di un genoma a doppia elica di DNA.
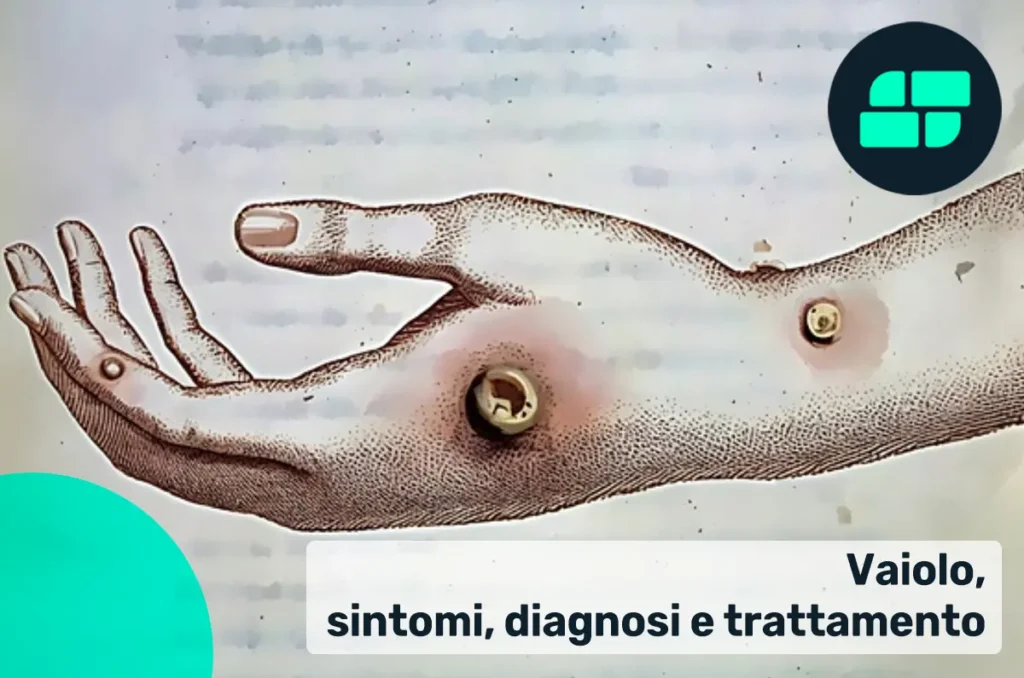
Le tracce del vaiolo si perdono nei secoli, con testimonianze che risalgono ad almeno tremila anni fa, come mostrano alcuni ritrovamenti archeologici tra cui mummie dell’antico Egitto. La svolta scientifica si ebbe nel 1796, quando Edward Jenner mise a punto il primo vaccino utilizzando una forma attenuata del virus bovino. Questo evento segnò l’inizio della moderna vaccinologia.
Nel XX secolo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità lanciò una campagna planetaria per eliminare il vaiolo. Tra il 1967 e il 1980, grazie a vaccinazioni di massa e a un sistema di isolamento dei casi, fu possibile arrestare la trasmissione. L’ultimo caso naturale noto si verificò in Somalia nel 1977. Nel 1980, il vaiolo fu ufficialmente dichiarato eradicato
Il vaiolo si diffonde in modo molto efficace da persona a persona, seguendo un percorso ben definito che coinvolge l’apparato respiratorio, il sistema linfatico e i tessuti cutanei, con effetti complessi sia sul piano fisiologico che anatomico.
La trasmissione avviene principalmente attraverso l’aria, mediante l’inalazione di piccole gocce di saliva emesse da soggetti infetti durante la parola, la tosse o gli starnuti. Altre modalità comprendono il contatto diretto con oggetti contaminati da fluidi corporei, come indumenti o biancheria, e, meno frequentemente, il contatto con le lesioni della pelle. Pur non resistendo a lungo nell’ambiente, il virus riesce a diffondersi con facilità in spazi chiusi e poco ventilati.
Una volta inalato, il virus raggiunge la mucosa della gola e del tratto respiratorio superiore, dove inizia a replicarsi nelle cellule epiteliali. Successivamente invade i tessuti linfatici associati alle mucose, attivando la risposta immunitaria iniziale. Nei primi giorni, si diffonde ai linfonodi regionali e da lì entra nel sangue, dando origine alla prima viremia.
Intorno al decimo giorno, il virus si dissemina nuovamente nel sangue (seconda viremia), raggiungendo organi come milza, fegato, midollo osseo e pelle. Questo passaggio coincide con la comparsa dei sintomi generali e con una risposta immunitaria più estesa.
Uno degli effetti più evidenti dell’infezione è il coinvolgimento della pelle, dove il virus provoca un’infiammazione significativa. Le lesioni cutanee attraversano varie fasi evolutive, da macchie a pustole, fino alla formazione di croste. Queste pustole, spesso profonde, possono lasciare cicatrici permanenti. In questa fase si osserva un’intensa risposta immunitaria locale, ma non sempre sufficiente a bloccare l’evoluzione della malattia.
In alcuni casi, l’infezione può colpire organi vitali e causare gravi complicanze. Il cervello può essere interessato da encefaliti, i polmoni da infezioni gravi, e gli occhi da infiammazioni che possono condurre alla cecità. L’ampia diffusione del virus nell’organismo può infine indebolire il sistema immunitario fino a causare sepsi o altre infezioni secondarie potenzialmente fatali.
A differenza di molti altri virus, è in grado di replicarsi autonomamente nel citoplasma cellulare, grazie alla presenza di tutti gli enzimi necessari alla trascrizione e alla replicazione, senza dover entrare nel nucleo della cellula ospite.
Dopo l’esposizione al virus, il tempo di incubazione oscilla generalmente tra 7 e 19 giorni, con una media intorno ai 12 giorni. L’infezione avviene per via aerea e il virus si insedia inizialmente nella gola, per poi passare attraverso il sistema linfatico e diffondersi nel sangue. Da qui, raggiunge la pelle e altri tessuti. I primi sintomi si manifestano con febbre alta, dolori diffusi, nausea e sensibilità alla luce. Dopo alcuni giorni compare un’eruzione cutanea che attraversa diverse fasi: macchie rosse, papule, pustole e infine croste. Le lesioni, una volta guarite, possono lasciare cicatrici permanenti.
Tipologie cliniche del vaiolo e livelli di severità
Il vaiolo si presenta principalmente in due forme: la variola major, più grave e con un tasso di mortalità che può arrivare al 30%, e la variola minor, decisamente meno letale, con mortalità inferiore all’1%.
Tra le manifestazioni cliniche della variola major si distinguono quattro varianti:
- Forma comune: rappresenta la maggioranza dei casi, con eruzioni cutanee evidenti;
- Forma modificata: più lieve, si verifica in persone vaccinate;
- Forma piatta: rara e severa, con lesioni che non si sollevano dalla pelle;
- Forma emorragica: estremamente rara ma mortale, si accompagna a sanguinamenti interni.
Sintomi
Il virus si diffonde prevalentemente non solo attraverso l’aria, con le goccioline respiratorie espulse da individui infetti durante conversazione, starnuti o tosse. Può inoltre trasmettersi toccando oggetti contaminati come indumenti o lenzuola.
Il vaiolo si manifesta con una sequenza ben definita di sintomi, che seguono un andamento progressivo articolato in diverse fasi. Dopo l’infezione iniziale, la malattia si sviluppa attraverso un periodo di incubazione privo di sintomi, seguito da una fase sistemica intensa e infine da manifestazioni cutanee caratteristiche.
Durante l’incubazione, il virus si replica silenziosamente nell’organismo, senza causare sintomi evidenti. In questa fase, la persona infetta non è ancora contagiosa, anche se l’infezione è già attiva nei tessuti linfatici e cellulari.
Segue una fase prodromica della durata di 3–4 giorni, in cui compaiono segni clinici generali: febbre elevata, cefalea intensa, dolori muscolari diffusi, senso di affaticamento, nausea, vomito, dolori addominali, fotofobia e dolore lombare. In questa fase, la persona diventa contagiosa anche se non sono ancora presenti eruzioni sulla pelle.
La fase successiva è quella cutanea, in cui compare l’esantema, ovvero l’eruzione di lesioni cutanee, che inizia tipicamente dal volto per poi estendersi ad arti e tronco, con maggiore densità su viso e estremità rispetto al resto del corpo. Le lesioni attraversano una successione ordinata di trasformazioni: iniziano come macchie piatte (macule), si sollevano formando noduli (papule), si riempiono di liquido (vescicole), diventano piene di pus (pustole) e infine si seccano in croste. Queste ultime cadono entro due o tre settimane, spesso lasciando cicatrici permanenti. Durante la fase delle pustole, può verificarsi una nuova impennata febbrile, nota come febbre bifasica, tipica di questa patologia.
| Fase | Durata tipica | Sintomi prevalenti | Contagiosità |
|---|---|---|---|
| Incubazione | 7–19 giorni (media 10–14) | Nessun sintomo; il virus si replica silenziosamente a livello cellulare e nei linfonodi. | ❌ Non contagiosa (it.wikipedia.org, cdc.gov) |
| Prodrome | 2–4 giorni | Febbre alta (38–40 °C), cefalea, malessere grave, mialgie, mal di schiena, nausea, vomito, dolore addominale, faringite, brividi | ⚠️ Contagiosa (possibilmente) |
| Eruzione iniziale | ~4 giorni | Lesioni in bocca/orofaringe; esantema facciale e distribuito in modo centrifugo; macule → papule → vescicole → pustole; febbre bifasica | ✅ Contagiosa |
| Pustole e croste | ~10 giorni | Pustole spesse, sode e profonde (4–6 mm), con umbilicazione; progressiva formazione di croste entro 9° giorno dall’esantema | ✅ Contagiosa |
| Caduta delle croste | ~6 giorni | Le croste si staccano, lasciando cicatrici; decorso fino a circa 3 settimane dall’esordio | ✅ Contagiosa fino alla completa caduta delle croste |
| Fase finale | ~4 settimane totali | Guarigione con cicatrici tipiche; scompare la contagiosità dopo la caduta delle croste | ❌ Non contagiosa dopo la fine dell’eruzione |
Durante il decorso del vaiolo, possono insorgere diverse complicanze che aumentano la gravità della malattia e il rischio di esiti negativi. Le complicazioni possono essere dirette, causate dall’azione stessa del virus, oppure secondarie, dovute a infezioni batteriche sovrapposte o a danni agli organi provocati dalla risposta infiammatoria.
Tra le complicazioni si riscontrano frequentemente cicatrici deturpanti, danni alla vista fino alla cecità, infiammazioni cerebrali, infezioni respiratorie gravi e sovrainfezioni batteriche.
| Complicazione | Descrizione | Impatto clinico |
|---|---|---|
| Cicatrici permanenti | Lesioni cutanee che lasciano segni evidenti, soprattutto sul viso | Estetico e psicologico, molto comune |
| Cecità | Coinvolgimento degli occhi con cheratite e danni alla cornea | Disabilità permanente |
| Encefalite | Infiammazione cerebrale causata dal virus o da reazione autoimmune | Danni neurologici, potenzialmente fatale |
| Polmonite | Infezione polmonare, spesso batterica secondaria, dopo l’infezione virale | Alta mortalità senza trattamento adeguato |
| Infezioni secondarie cutanee | Sovrainfezioni batteriche di lesioni cutanee da rottura delle pustole | Peggioramento locale, rischio di sepsi |
| Disidratazione | Perdita di liquidi causata da febbre e lesioni cutanee | Peggiora lo stato generale, necessita reidratazione |
| Sepsi | Risposta infiammatoria sistemica a infezione virale o batterica | Condizione critica, potenzialmente mortale |
Diagnosi
La diagnosi del vaiolo si basa principalmente sull’osservazione dei sintomi clinici tipici, in particolare l’eruzione cutanea caratteristica che si sviluppa in modo sincronizzato attraverso diverse fasi — macule, papule, vescicole e pustole — con una distribuzione che interessa maggiormente il volto e gli arti. Non esistono scale standardizzate per valutare la gravità della malattia, pertanto la diagnosi iniziale si fonda sull’analisi delle lesioni cutanee e sulla storia di possibile esposizione al virus.
Per confermare la presenza del virus Variola, vengono impiegate tecniche di laboratorio specifiche. La reazione a catena della polimerasi (PCR) rappresenta il metodo di riferimento, grazie alla sua elevata sensibilità nel rilevare il DNA virale in campioni di lesioni cutanee, sangue o secrezioni respiratorie. In laboratori specializzati si può effettuare anche la coltura virale, sebbene sia più lenta e complessa. Ulteriori tecniche, come l’immunofluorescenza e l’immunoistochimica, permettono di identificare antigeni virali nei tessuti. Gli esami sierologici, meno frequenti, possono essere utili per diagnosi retrospettive attraverso il rilevamento di anticorpi specifici.
Considerata l’elevata pericolosità del virus, i campioni devono essere maneggiati esclusivamente in strutture con un alto livello di biosicurezza (BSL-4). Una diagnosi tempestiva e accurata è cruciale per impedire la diffusione del vaiolo e controllare eventuali focolai.
La prevenzione si basa essenzialmente sulla vaccinazione. Storicamente si utilizzava il vaccino ACAM2000, contenente virus vivo attenuato. Attualmente, si predilige l’impiego del MVA-BN (conosciuto come Imvanex o Jynneos), un vaccino non replicante autorizzato anche contro virus correlati come il monkeypox.
Non esistono cure specifiche per il vaiolo nei pazienti, ma alcuni antivirali come tecovirimat, brincidofovir e cidofovir sono stati approvati per l’uso in scenari di emergenza, soprattutto in caso di attacchi bioterroristici.
Anche se la malattia non è più presente in forma naturale, istituzioni come l’OMS e il CDC continuano a monitorare il rischio di reintroduzione, specialmente attraverso incidenti di laboratorio o utilizzo a fini bellici. È noto, ad esempio, il caso del 1978 in Gran Bretagna, dove una fuoriuscita del virus in un centro di ricerca portò a un’infezione mortale. Questi eventi rafforzano l’importanza di regole stringenti in termini di biosicurezza, ricerca e stoccaggio dei campioni virali.